|
|
| |
|
|
Er davenì
di Enrico Meloni
Pubblicato su SITO
Anno
2007-
Progetto Cultura
Prezzo €
10-
96pp.
Le scommesse - Poesia
ISBN
9788860920591
Una recensione di
Carlo Santulli
|
|
VOTA QUESTO TESTO
|
|
|
|
Votanti:
512
Media
81.02%
|
|
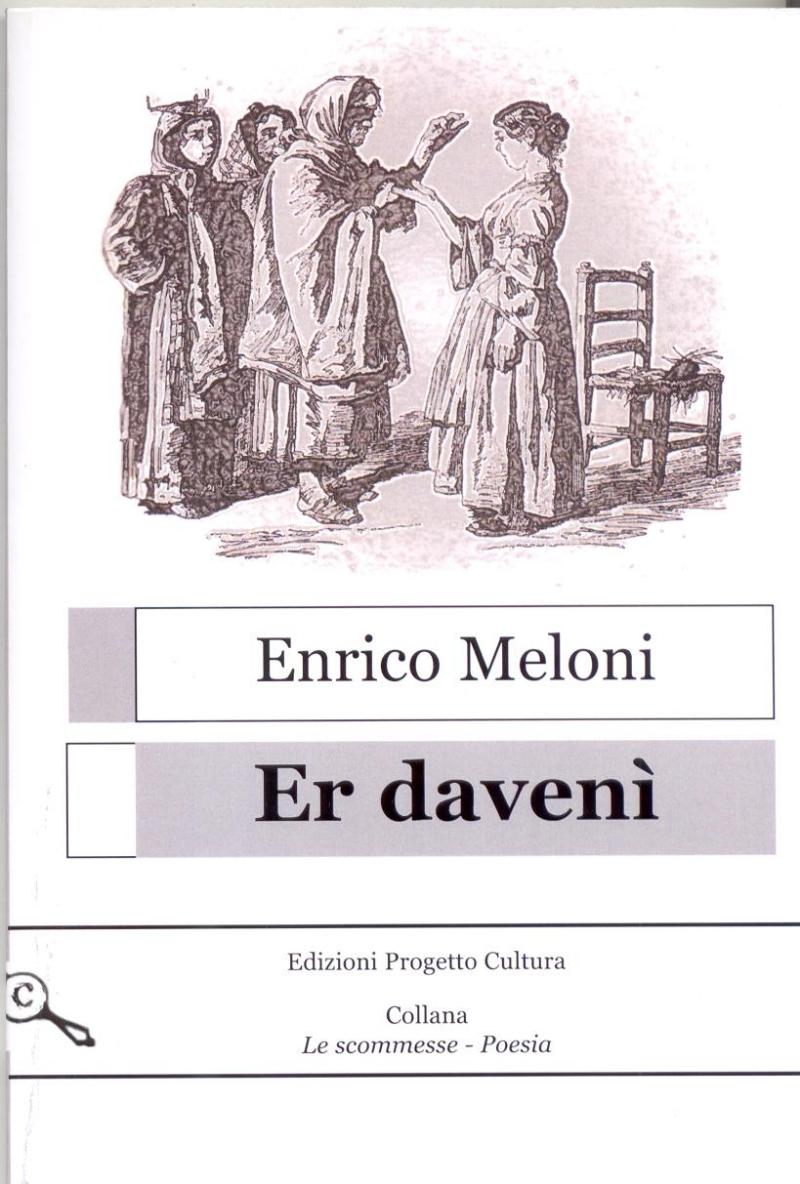
|
|
Chiamatela scommessa, come dal titolo della collana di Progetto Cultura che lo pubblica, o chiamatela sfida, un termine che piace senz'altro di più nel mondo anglosassone, la verità è che questo poemetto romanesco, “Er davenì”, con cui mi sembra che Enrico Meloni trovi una sua misura giusta ed adeguata di narratore in poesia, esce fuori per una serie di motivi dalle vie battute nel passato recente dalla nostra letteratura.
Prima di tutto c'è la necessità di una poesia civile, o meglio di una poesia che spieghi la storia, partendo dai sentimenti, quindi nascendo da un campo lirico e personale, e facendo leva sul fatto, indubitabile, che alla storia non ci si sottrae: al meglio la si sopporta, come nel caso di un soldato che parte, più o meno malvolentieri, per la guerra.
Una vittima senza vittimismo, si potrebbe definire quel militare “[...] de stanza/sur mare de Croazzia a Sebbenico“: senza vittimismo, e pieno di una dignità, che non esclude la nostalgia, ma virile, intensa, cerca di spiegare cosa non va nella guerra dai fatti che man mano gli accadono, più che lamentarsi alla cieca. Catturato dopo l'armistizio, e finito in quella categoria, che ben conosciamo, per esempio dai ricordi ostinatamente agrodolci di Guareschi, degli Internati Militari Italiani (IMI), il bersagliere Luigi non perde la propria fisionomia, il proprio calore umano, pur tra le mille traversie della fame e della prigionia. Un calore, che predice ed ispira quasi una piccola epica, nel furto di carichi di patate, nella possibile cattura di un capretto.
Il secondo aspetto essenziale è proprio nell'uso diacronico e civile del dialetto: di entrambi, in certo senso, aveva dato esempio Cesare Pascarella, nei sonetti de “La scoperta dell'America” dove tra la voce e le vicende del narratore e quella dei fatti narrati corrono quattro secoli, ed in quelli di “Villa Gloria”, dove l'epopea garibaldina è fatta scendere dal piedistallo della retorica nazionale tardo-ottocentesca con un solido afflato realistico. Ecco, vorrei dire che Meloni muove un passo oltre, nel senso proprio della pregnanza del racconto, scindendo i due piani temporali, anche dal punto di vista del linguaggio. Non ha paura di riconoscere che il dialetto degli anni '40 è molto faticosamente ricostruibile nella parlata attuale, e quindi lo storicizza, mentre utilizza quest'ultima, con una struttura da tragedia greca, nei corettacci, che con cadenza prevalentemente di senari, aprendosi poi a lasse d'endecasillabi, il che ricorda metricamente ed anche un po' foneticamente certi passi di Arrigo Boito librettista, commentano non solo il passato, ma il futuro, “er davenì” appunto. Ma non siamo capitati in un coro d'opera, che non fa che inveire, e lanciare malefici. E' vero che un po' di rimpianto lo danno dei distici come “Se so' penzati d'arivortà er monno/de monnallo da chiaviche de zzelle/quarcuno l'ha pagata co la pelle/che d'è cambiato?...Jé toccato er fonno”. Invece, il corettaccio sa anche aprirsi ad effetti più rapsodici, in certo senso, come per esempio quando riflette sul fatto che “chi semina vento raccoglie buriana”: “(Potrebbero avecce/bojaccia miseria/e vento e bburiana/l'istessa banniera?)” ed anche a neologismi come la “gnunquità”, l'essere nessuno e chiunque. “Gnunquità” che esprime forse bene l'essenza di questo poemetto che vuole porsi fuori dal tempo e dallo spazio, paradossalmente utilizzando la lingua parlata dal popolo, che è necessariamente incatenata sia al proprio tempo che al luogo dove si manifesta. Credo che questo, alla scuola di Franco Loi, il grande poeta dialettale milanese, giustamente citato da Meloni nella “Nota dell'autore” che precede il testo, indichi che niente esprime meglio il senso della letteratura che il rifiuto della letterarietà, travolta dalla vita: in quel momento, l'unica lingua può essere quella che l'autore ha dentro, anche subliminalmente, in molti casi un dialetto, ma desublimato ed in certo senso epicizzato.
Una recensione di Carlo Santulli
Recensioni ed articoli relativi a
Enrico Meloni
(0) Arca allo sbando? di Enrico Meloni - Il Parere di PB
(1) Quando gli squali mangiano vento di Enrico Meloni - Il Parere di PB
(2) Er davenì di Enrico Meloni - Il Parere di PB
Testi di
Enrico Meloni pubblicati
su Progetto Babele
(1) Rasella: storia di una bomba di Chiara Castagna - RECENSIONE
(2) Canto del pescatore di Hammamet di Enrico Meloni - POESIA
(3) La corsa del bosco di Enrico Meloni - RACCONTO
(4) Ginger di Enrico Meloni - RACCONTO
(5) Naghib di Enrico Meloni - RACCONTO
Recensioni ed articoli relativi a
Carlo Santulli
Nessun record trovato
Altre recensioni
di
Carlo Santulli
(1) La qualità dei sentimenti di Giampaolo Giampaoli - RECENSIONE
(2) Quei gran pezzi dell'Emilia Romagna di Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini - RECENSIONE
(3) Sandino Il generale degli uomini liberi di Maurizio Campisi - Il Parere di PB
(4) La gallina volante di Paola Mastrocola - Il Parere di PB
(5) Il 1848 e le cinque giornate di Milano di Antonio Monti - Il Parere di PB
(6) Operazione Arca di Noè di Andrea Coco - Il Parere di PB
(7) Il castello incantato di Emiliano Grisostolo - Il Parere di PB
(8) Cassandra di Laura De Santis - Il Parere di PB
(9) Cuore e acciaio - estetica dell'animazione giapponese di Marcello Ghilardi - Il Parere di PB
(10) La nascita della bellezza - da Bruegel a Basquiat ritratti di un mondo segreto di Maria Grazia Mezzadri Cofano - Il Parere di PB
>>Continua (click here)
Libri di pubblicati nella collana I libri di PB
Copertina |
Scheda Libro |
Compralo ora! |

|
Prefazione / Indice / Scheda
Ghigo e gli altri
di Carlo Santulli
2007 pg. 204 - A5 (13,5X21) BROSSURATO
Prezzo Amazon 8.31 euro
Altre informazioni / L'autore
Pochi autori, come Carlo Santulli, sanno giocare con le parole, intarsiandole in piccole storie che si snodano tranquille (mai lente) attraverso una realtà quasi ordinaria e che, pure, riescono ad affascinare il lettore costringendolo a leggere fino all'ultima riga. Personaggi stupiti, a volte impacciati, si aggirano tra le pagine di questo libro, alle prese – come tutti noi – con le incongruenze e le follie del vivere quotidiano, non si abbandonano però all'autocommiserazione, non si ribellano, non cedono a tentazioni bohemien e, se cercano una via di fuga, questa è piuttosto interiore che esteriore. Un cammino, a piccoli passi, che li porterà, forse, verso un punto di equilibrio più stabile. Irraggiungibile (ma reale) come un limite matematico. Siano essi alle prese con una Quinta Arborea, un mazzo di chiavi che si trasforma nel simbolo di un'esistenza, un Clostridio tra i Pirenei, o passeggino, semplicemente, per le strade di una sonnolenta Roma anni trenta.(Marco R.Capelli)
|
|

|
Prefazione / Indice / Scheda
Ghigo e gli altri
di Carlo Santulli
2010 pg. 200 - A5 (13,5X21) COPRIGIDA
Altre informazioni / L'autore
Pochi autori, come Carlo Santulli, sanno giocare con le parole, intarsiandole in piccole storie che si snodano tranquille (mai lente) attraverso una realtà quasi ordinaria e che, pure, riescono ad affascinare il lettore costringendolo a leggere fino all'ultima riga. Personaggi stupiti, a volte impacciati, si aggirano tra le pagine di questo libro, alle prese – come tutti noi – con le incongruenze e le follie del vivere quotidiano, non si abbandonano però all'autocommiserazione, non si ribellano, non cedono a tentazioni bohemien e, se cercano una via di fuga, questa è piuttosto interiore che esteriore. Un cammino, a piccoli passi, che li porterà, forse, verso un punto di equilibrio più stabile. Irraggiungibile (ma reale) come un limite matematico. Siano essi alle prese con una Quinta Arborea, un mazzo di chiavi che si trasforma nel simbolo di un'esistenza, un Clostridio tra i Pirenei, o passeggino, semplicemente, per le strade di una sonnolenta Roma anni trenta.(Marco R.Capelli)
|
|
|
Altre
recensioni:
|
|
|
|
|