|
|
| |
|
|
Le alpi
di Marco Cuaz
Pubblicato su SITO
Anno
2005-
Il Mulino
Prezzo €
12-
199pp.
ISBN
2147483647
Una recensione di
Luca Bidoli
|
|
VOTA QUESTO TESTO
|
|
|
|
Votanti:
10503
Media
79.71%
|
|
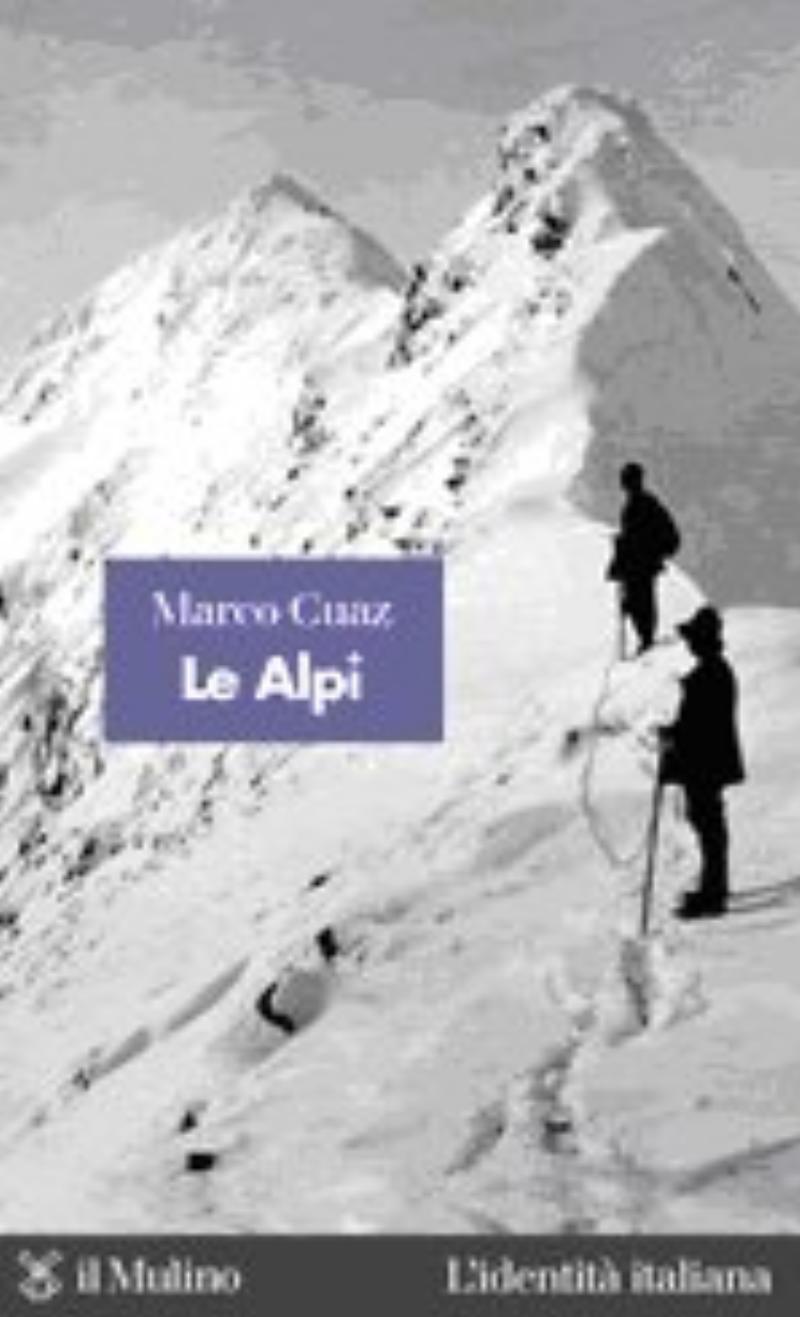
|
|
Da tempo l'attenzione degli storici si sofferma su elementi che solo apparentemente si collocano nella dimensione del paesaggio o della geografia, per andare invece a ricercare, al di là del mero fatto fisico e naturale, le profonde valenze simboliche, gli usi politici, le letture e le interpretazioni in chiave patriottica e nazionale, le differenziazioni di prospettiva e di visuale che epoche diverse attuano nei confronti dei punti di contatto o di contrapposizione, siano essi fiumi - qui il riferimento immediato è al celebre volume che Lucien Febvre dedica al Reno - o ad altri luoghi tipici di paesaggi culturali e immaginari, di proiezioni simboliche come acque, foreste, singoli monti o intere catene montuose. Contatto/contrapposizione: non sono mai, va da sé, termini e valori assoluti, ma si situano anch'essi all'interno di specifici contesti storici, nei quali elementi naturali assumono valenze e significati profondamente diversificati in ragione del modo e degli strumenti che vengono applicati per la loro definizione. Le Alpi ben si prestano ad una ricognizione che ne strutturi ed indaghi le modificazioni nella loro percezione e lettura: dalla distanza con le quali vengono osservate e lette dagli umanisti- l'umanitas si realizza e si configura nella razionalità di una civitas, riprendendo quella svalutazione che era stata già propria al mondo romano, nel quale l'altezza era inversamente proporzionata alla civiltà -sino al rinnovato, esteso interesse d'epoca moderna dapprima quasi esclusivamente militare e scientifica, poi di natura più specificatamente patriottica e nazionale, nel momento in cui si inseriscono le dinamiche di identificazione Risorgimentale. Vi è, tra questi due passaggi, una fase intermedia, che, scalfendo una visione troppo utilitaristica e razionalistica, affronta, con il fervore del pieno e maturo Romanticismo, le vette alpine quali metafore di percorsi di iniziazione individuale e di crescita soggettiva. Le grandi catene montuose delle Alpi quali laiche cattedrali di pietra, eterne, spazi sacri, puri: di quella purezza ed innocenza che le civiltà delle rivoluzioni industriali sembravano aver smarrito per sempre, nella produzione seriale di materiali di pronto consumo e di esseri umani che vengono altrettanto consumati, erosi nelle moderne catene di montaggio.
I grandi viaggiatori inglesi dell'età vittoriana, in special modo, ricchi, colti, gente strana, anche pericolosa -protestanti, in realtà riconquistate non sempre senza fatica, alla piena e controllata cattolicità- creano quei miti dell'escursionismo alpino che, introducendo quelle vallate nel processo di modernizzazione, avrebbero, nel bene come nel male, costretto la gente di quei luoghi a ridefinire la propria identità. In questo contesto emergono le figure essenziali dei parroci di montagna e delle guide: sono loro i mediatori culturali che si frappongono tra i nuovi e stranieri, venuti chissà da dove, e le realtà locali. Si fanno portavoce degli interessi locali, delle esigenze peculiari di un mondo che va ridefinito e protetto. Perché ogni novità è sì catalizzatrice di nuove energie e professionalità che emergono, ma crea anche i presupposti per stili e sistemi di valori prima inesistenti. Le vette: la conquista dell'inutile. Certo nessun montanaro, in questa accezione, era stato un alpinista, sino a quando non arrivarono gli inglesi, gli stranieri.
Le Alpi anche come luogo specifico di contesa e di identità che si affinano attraverso sfide e vette da conquistare in virtù della propria appartenenza nazionale, quali palestre dove forgiare caratteri forti e temprati alla loro difficile scuola. Sono le Alpi contese, tra la fine dell'ottocento e gli inizi del nuovo secolo, l' era dei nazionalismi e degli imperialismi, secondo la fortunata definizione di Hobsbawn, dell'associazionismo patriottico, delle società alpinistiche. Qui ci preme ricordare la Società degli alpinisti triestini, nata nel capoluogo giuliano nel 1883, denominata tre anni dopo, Società alpina delle Giulie ( Sag ), nelle cui vicende traspaiono le vicissitudini di una montagna contesa, vera prefigurazione non armata, ma ideologica, di quanto si sarebbe verificato di lì a non molto. Come ci ricorda l'autore la Sag “ aderirà al Club alpino italiano nel 1921, aggiungendo allo statuto, tra gli scopi dell'associazione, < il culto delle Terre Sacre>. A simbolo ed eroe della società verrà promosso l'irredentista slavofobo Ruggiero Timeus, colui che riteneva che (...)” ( p. 57).
Di estremo interesse risultano anche le pagine sull'associazionismo cattolico e sui cospicui investimenti che la Chiesa cattolica, soprattutto all'indomani della Rerum Novarum, dispiega sul versante delle iniziative volte ad attivare, attraverso l'invenzione delle case per ferie, soggiorni di studio, meditazione e cura d' anime, verso allievi e seminaristi, ma anche semplici simpatizzanti, con particolare attenzione verso i giovani. E' curioso notare come sia stato proprio l'associazionismo cattolico il primo a portare in forme collettive ed organizzate le donne sulle Alpi, essendo preclusa la loro adesione ai club alpini.
Il grande spartiacque epocale rimane tuttavia il primo conflitto mondiale, è quella guerra aspramente combattuta sui fronti alpini, a sacralizzare la frontiera , a trasformare le vette, le vallate, le cime delle Alpi, dalla barriera che protegge l'Italia dai barbari, in un sacrario della Patria, luogo di identificazione e di collante nel culto di monti resi sacri dal sangue italiano. Un modello che il fascismo riprenderà con il sovrappiù del culto eroico volto all'estremo, ma anche di una nuova Italia sportiva e moderna, al passo con i tempi e con le altre nazioni europee. Nella creazione di un nuovo tipo di italiano, votato al coraggio e alla determinazione, seguendo un modello che un'icona dell'alpinismo italiano dell' epoca, Emilio Comici, il grande rocciatore triestino, incarnava nelle frasi con le quali chiudeva i suoi interventi a convegni o conferenze: “Si deve osare; il duce ha insegnato così”.
Il disincanto, la tragedia spetteranno in particolar modo alle truppe alpine, nelle desolate steppe russe, nel ghiaccio dei fiumi e delle immense pianure, nella guerra che Mussolini forse pensava già conclusa, e che tanti, troppi italiani si troveranno a combattere in condizioni di penosa e colpevole inferiorità. Un finale che può essere riscattato solo attraverso la nuova consapevolezza che le Alpi, da luogo innervato di trame sovente antagoniste e in contrapposizione, siano e divengano quella regione europea, laboratorio di reali e nuovi modelli di convivenza e pacificazione, non in virtù di astratte idee irenistiche, ma partendo dal dato pratico reso dal passato comune di genti che si sono, nei secoli, identificate in proiezioni e in dimensioni di una forte e sostanziale appartenenza condivisa.
Una recensione di Luca Bidoli
Recensioni ed articoli relativi a
Marco Cuaz
(0) Le alpi di Marco Cuaz - RECENSIONE
Recensioni ed articoli relativi a
Luca Bidoli
Nessun record trovato
Altre recensioni
di
Luca Bidoli
(1) Io con vestito leggero di Livia Candiani - RECENSIONE
(2) Il bisogno di Patria di Barberis Walter - RECENSIONE
(3) La fine. Amburgo 1943 di Hans Erich Nossack - RECENSIONE
(4) Nel bunker di Hitler di Bernd Freytag von Loringhoven - RECENSIONE
(5) La ragazza del secolo scorso di Rossana Rossanda - RECENSIONE
(6) Come mio fratello di Uwe Timm - RECENSIONE
(7) La città del tardo Rinascimento di Claudia Conforti - RECENSIONE
Altre
recensioni:
|
|
|
|
|